
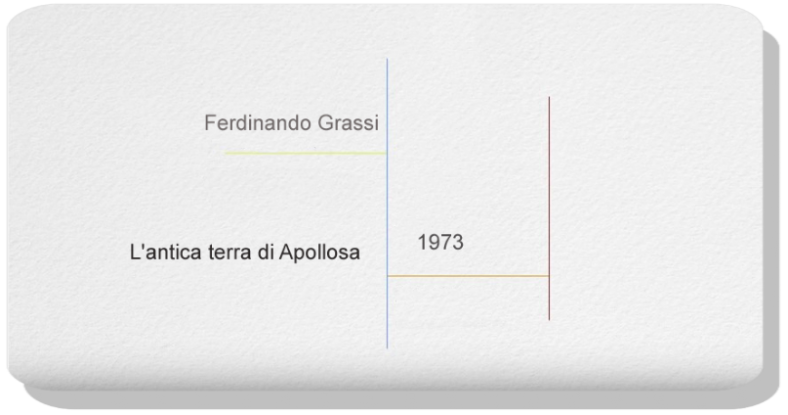
Le origini di Apollosa in certo qual modo derivano da quelle dell'odierna Benevento, la città capoluogo del Sannio che sorse alla confluenza del Sabato e del Calore, i due fiumi che irrigano la zona. Sebbene non storicamente accertato, forse fu questa felice dislocazione topografica il fattore determinante che spinse i fondatori della futura Benevento, senza dubbio pastori, a scegliere il punto di tale confluenza come propria sede: tra i due fiumi si formava un triangolo di terraferma su cui essi potevano, anche nei mesi invernali, porre al sicuro le loro greggi dagli attacchi delle fiere selvatiche. Nel Museo del Sannio è tuttora conservata una preziosa moneta su cui è inciso il nome «osco» Malies che venne dato al triangolo cui abbiamo accennato; tale termine venne poi dagli studiosi interpretato con il significato di ritorno delle greggi.

Moneta bronzea del IV secolo a.C. riportante la scritta Malies sull'esergo, oltre ad una testa di donna con la capigliatura chiusa in un sakkos; sul rovescio sono raffigurati un bue con volto umano, ed in alto una testa barbata ( fonte:wikipedia 2013 ).
Ai primitivi abitanti della zona si sovrapposero poi coloni greci, provenienti forse dall'Eubea i quali modificarono, come era loro uso, le denominazioni locali. Quindi l'originario nome Malies sarebbe divenuto Maloeis e successivamente Maloenton. Tale accusativo alla greca avrebbe poi subito una nuova trasformazione, nel latino Maleventum, allorché i Romani imposero la propria dominazione nel centro sud della penisola.

La città così denominata balzò poi agli onori della cronaca durante le cosiddette guerre sannitiche: una prima volta nel 321 a. C., quando le legioni romane dovettero subire l'umiliazione delle Forche Caudine e, successivamente, nel 276 a. C. quando le truppe di Curio Dentato riportarono clamoroso e definitivo successo sul re epirota Pirro. Fu in tale occasione che, secondo il racconto di Tito Livio, il nome di Maleventum sarebbe stato, per acclamazione dei soldati vittoriosi, mutato in quello più fausto di Beneventum.Cessato il fragore delle armi, i Romani si preoccuparono di incrementare i commerci nelle terre conquistate e di collegare queste ultime con la capitale; da qui la costruzione di una fitta e razionale rete viaria che vide il Sannio attraversato in un primo momento dalla Via Latina e dalla Via Egnazia e successivamente dalla Via Appia, la famosa «regina viarum» che testimoniò, dal Campidoglio al molo di Brindisi, la grandezza romana.
Le antiche origini del nome Apollosa, quello che indica il Comune oggetto di questo succinto lavoro, sono direttamente collegate al sistema viario dei Romani. Questi erano soliti segnare ogni miglio (= 1481 m.) delle loro arterie con un cippo o lapillus miliarius; intorno ai più importanti di questi cippi sorgeva una vera e propria area di servizio ante litteram, con possibilità di vitto, di alloggio e di cambio dei cavalli. Dall'espressione lapillus miliarius derivò il nome Lapillusia, per indicare un posto di ristoro sorto nei pressi di un cippo lungo la via per Benevento. L'odierna forma Apollosa si ebbe dopo il crollo dell'Impero romano, quando ormai la latinità era dimenticata ed il popolino storpiava, nella propria ignoranza, i vari nomi propri.

Ponte Taverna [ Acquerello in seppia, tracce di matita ]-STAMPA -1789 -
Nel 1101 il cronista Falcone Beneventano scriveva ancora «Lapillusia», mentre non siamo lontani dal vero nel ritenere che se un notaio avesse richiesto il paese di origine a qualche indigeno sprovvisto di cultura, questi avrebbe risposto: «so' dell'Apillosa»; «so' della Pellosa». Le persone in grado di saper scrivere correggendo secondo un proprio criterio personale le parole che sembravano errate avrebbero scritto Apollosa. Questa è la teoria che riteniamo più rispondente al vero, anche perché quella che fa risalire il nome di Apollosa al mitico Apollo è senz'altro da scartarsi. Data la situazione strategicamente e topograficamente importante di questo antico centro, sito come era sulla via per Benevento, esso vide passare uomini di governo ed eserciti destinati ad avere poi ruoli di primo piano nella nostra storia. Ricorderemo che lo storico tedesco Teodoro Mommsen studiò a lungo, ricavandone conforto per le proprie teorie, un'iscrizione risalente al 200 d.C., rinvenuta nei pressi di Apollosa. Anche al periodo romano molto probabilmente risale il castello omonimo, che una volta avrà ricoperto il ruolo di torre di vedetta in quanto sito su di una collina che dominava il passo per Benevento.La successiva storia del castello di Apollosa si identifica, grosso modo, con quella del paese nel quale sorgeva e ciò trova conferma nella cronaca di Falcone Beneventano. Questi ci fornisce numerosi particolari delle vicende storiche del castello, in particolar modo di quelle svoltesi al tempo dei Normanni. Ci ricorda, per esempio, che Ruggero D'Altavilla, deciso a conquistare la città papale di Benevento, chiese l'intervento di Ugone Infante, signore di Apollosa, il quale rinchiuse nei sotterranei del castello un gran numero di prigionieri beneventani. Inutilmente Apollosa fu assediata dalle forze congiunte di papa Onorio II, del principe Roberto, del conte Rainulfo e di Guglielmo di Benevento: gli attaccanti, che avevano incendiato la selva circostante il castello, dovettero desistere dai loro tentativi e ritirarsi sconfitti (27 gennaio 1127).
Falcone Beneventano continua la sua cronaca raccontando come papa Onorio II, dopo lo smacco subito ad Apollosa, si decise a concedere l'investitura di Puglia, di Salerno e di Capua ad un nuovo alleato di ben diverso potenziale bellico: Ruggero II di Altavilla. Questi, in soli quattro giorni di assedio, ebbe ragione della resistenza di Ugo Infante ed espugnò il castello di Apollosa, vero nido d'aquila.Il castello di Apollosa ritorna alla ribalta della storia con Federico II di Svevia, il quale dopo la distruzione di Benevento toglie il territorio di Apollosa ai frati benedettini di S. Sofia di Benevento. Successivamente la baronia di questo comune fu concessa ad Emanuele Frangipane, quale ricompensa del tradimento da questi operato e che comportò la decapitazione del giovanissimo Corradino di Svevia. Il 29 giugno del 1440 «nelle vicinanze del castello di Apollosa» si trovarono di fronte gli eserciti di Renato d'Angiò e di Alfonso d'Aragona, i quali si contendevano la successione al regno di Napoli apertasi cinque anni prima della morte della regina Giovanna II (febbraio 1395).Apollosa non è passata alla storia soltanto perché teatro di battaglie che spesso ebbero vasta risonanza, ma anche perché dette i natali ad uomini di cultura. Tra questi ne ricorderemo uno, del quale la lapide sepolcrale diceva: Hic situs est nostrae splendor Turpilius urbis grammaticus Prisci victor et ultor ani. Da tale lapide scaturisce una prima considerazione: il solo fatto che l'antica Apollosa venga definita urbs indica chiaramente che essa era cinta di mura e quindi doveva costituire un centro abitato di una certa importanza. Il sepolcro ornato della lapide che sopra abbiamo riportato custodiva, quindi, i resti di Turpilio studioso di grammatica. Egli avrebbe acquisito la sua cultura in materia studiando sui testi di un famoso maestro di Bisanzio chiamato Prisciano, non sappiamo se di nome o di soprannome. Questo Prisciano avrebbe insegnato a Bisanzio verso l'anno 430 e sarebbe stato autore di una poderosa opera, la Institutio de arte grammatica, in diciotto libri; i primi sedici trattavano di grammatica vera e propria e gli ultimi due di sintassi. Tale opera ci è abbastanza nota poiché un vescovo beneventano, di nome Orso, nell'anno 830 ne fece un ristretto con il titolo di Abbreviatio Prisciani; si tratta di quel compendio di cui si può ancora oggi ammirare una copia nella Biblioteca Casanatense di Roma.
____________________________________________
Fonte:
ARTICOLO PUBBLICATO IN
RACCOLTA RASSEGNA STORICA DEI COMUNI
VOL. 5 - ANNO 1973
___________________________________________
ISTITUTO DI STUDI ATELLANI
Rassegna Storica dei Comune
___________________________________________
Fotografie e riferimenti web a cura della Redazione
Angelo Savoia gennaio 2003